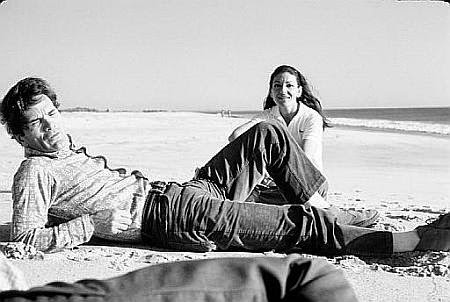Ma quant’è bella l’estate? Il profumo dei fiori, la natura che prorompe da ogni dove, il risvegliarsi degli esseri viventi più belli del creato: il dolce usignolo, il goffo riccio, le mosche, i tafani, le zanzare, i giornalisti che dicono agli anziani di andare ai centri commerciali perché lì c’è l’aria condizionata, gli stati di gente su Facebook che d’inverno scrive «Ma che palle sto freddo! Estate mi manki!» e d’estate «Uffa, sto caldo ma quando viene inverno?», il Meteo.it di Tgcom.
Il Meteo.it Tgcom merita una piccola digressione fra le cose più fastidiose dell’estate (a parte lo sfregamento dell’interno coscia quando si ritorna dalla spiaggia, grazie al quale l’industria del borotalco in questa stagione è seconda solo a quella della coca a Ibiza).
Per chi non avesse mai avuto la fortuna di vedere il Meteo.it Tgcom, farò qui un piccolo riassunto:
sullo schermo appare il/la meteorologo/a che col ditino indica la parte settentrionale dell’Italia dicendo: «A Torino si registra tempo sereno, a Milano alcune nubi provenienti dall’Europa settentrionale provocheranno lievi precipitazioni, a Venezia il cielo sarà sgombro di nubi…»; appena però il ditino si sposta appena sotto la riva meridionale del Po: «Per quanto riguarda il Mezzogiorno, tempo variabile» descrivendo ampi cerchi che vanno da Bologna al Mozambico. Il che potrebbe anche essere una scelta editoriale del tipo: «I nostri spettatori vivono per lo più al nord». Peccato però che per tutta la durata dei mesi di luglio e agosto ci abbiano veramente liofilizzato la zona meridionale del corpo tenendoci aggiornati sulla situazione meteorologica di amene località quali: la Papuasia, la Melanesia o la Micronesia Olandese.
Ora, dico io, che è sta Micronesia Olandese? Ma che ce ne frega se in Micronesia Olandese piove? Nemmeno gli abitanti della Micronesia Olandese sanno di vivere nella Micronesia Olandese!
Fine della digressione meteorologica.
Tuttavia fra tutti gli esseri che si risvegliano in estate ce n’è uno che merita la nostra attenzione: il Beatote. Ogni famiglia, comitiva, oratorio, scuola di cucito, gruppo fondamentalista religioso, ha almeno un esemplare di beatote, nel mio caso, per esempio, è una zia. La caratteristica principale del beatote è un malato ottimismo che si manifesta con frasi del tipo:
«Hai bucato una gomma? Beatote, io ho sfasciato la macchina»
«Ti si è scotta la pasta? Beatote, io sto da una settimana digiuna»
«Hai un po’ di tosse? Beatote, io c’ho la peste bubbonica, anzi vado che c’è un monatto che mi aspetta di sotto»
E via di seguito.
Come dicevamo però, è in estate che il beatote dà veramente il massimo: tu sei lì, che hai sfacchinato per tutto l’inverno a dare ripetizioni a un ragazzino che fino a giugno ha tentato di farti le macumbe su una bambolina che stranamente riproduceva le tue fattezze, ogni volta felice di vederti come una galeone spagnolo carico di schiavi africani, per permetterti di comprare un biglietto aereo (posto stiva, rigorosamente non pressurizzato) che ti porterà per due giorni in un ostello a Londra, dove dividerai il letto a castello con un turista austriaco che non lava i calzini da prima che cominciasse la deriva dei continenti.
Ebbene il giorno prima di partire il beatote, di ritorno da una crociera ai Caraibi costata quanto il prodotto interno lordo del Liechtenstein, si presenta a casa tua con ancora le infradito ai piedi e, con una faccia di una a cui è appena stata asportata l’appendicite senza anestesia, ti dice: «Beatote che vai a Londra, noi ci siamo proprio stressati sulla nave». Mettendo a dura prova la tua capacità di inventare nuovi e frizzanti vituperi in direzione sua e di tutti i suoi defunti (che, sfortunatamente, nel mio caso sono pure miei).
Nonostante i notori progressi della scienza moderna come la particella ultra assorbente dei salvaslip della Lines (embè? Mo vuoi vedere che il problema degli scienziati è l’ebola?), il mondo accademico non ha ancora trovato una soluzione definitiva alla piaga dei beatote (anche se un cric di acciaio inossidabile aiuta sempre).
Tuttavia, amici miei, non dovete disperare: come disse quello che aveva comprato un CD dei Dear Jack perché aveva letto che hanno venduto più di un milione di copie: «Mal comune, mezzo gaudio». Già, perché i beatote hanno fatto la loro comparsa sulla Terra alcuni secoli fa e ne troviamo traccia anche nella Letteratura e più precisamente nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis.
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis è il primo esempio di romanzo epistolare della Letteratura italiana, pubblicato per la prima volta nel 1802 da quel basettone di Ugo Foscolo. A scuola Ugo Foscolo è conosciuto soprattutto per le pazze risate che ci fa fare con i suoi versi come: illacrimata sepoltura (A Zacinto), l’ossa mie rendete/allora al petto della madre mesta (In morte del fratello Giovanni), né le città fur meste/d’effigiati scheletri (Dei sepolcri). Insomma, dalla poetica di Foscolo ci possiamo ricavare agevolmente uno di quei film che nei pomeriggi natalizi danno su Canale 5 o, in alternativa, tutta la filmografia di Tarantino.
Ma ritorniamo all’argomento principale.
Come dicevamo, le Ultime lettere di Jacopo Ortis è un romanzo epistolare, cioè scritto sotto forma di lettere che il protagonista manda ad un suo amico, Lorenzo Alderani. Quello epistolare era un genere che nell’Ottocento andava molto di moda e che sarebbe interessante vedere cosa ne verrebbe fuori al giorno d’oggi su Whatsapp.
Per mia nonna che non conosce la prosa cruda del XIX secolo: un limone è una pomiciata di una certa intensità.
Ma andiamo avanti…
Jacopo è uno studente universitario deluso dalla politica di Napoleone che, inaugurando una lunghissima tradizione di politici nostrani, ha deciso di svendere il Paese per un pezzo di pane e per questo il giovane decide di ritirarsi sui Colli Euganei, nei pressi di Padova. Qui Jacopo, che già di suo è allegro come una canzone dei Modà, sembra ritrovare un po’ di pace leggendo i classici latini se non che conosce un certo signor T. e la sua dolce famigliola costituita dalle figlie Isabellina e Teresa e dal futuro marito di quest’ultima, Odoardo.
Foscolo qui dimentica completamente di essere un grande scrittore e, manco si trattasse di un romanzo di Nicholas Sparks, fa innamorare follemente Jacopo di Teresa, quindi per diverse decine di lettere ci sembra di sentire la colonna sonora de Il tempo delle mele mentre leggiamo di sagre di paese a cui i due partecipano arrostendo salsicce di cinghiale mano nella mano, vanno a fare scampagnate nel paese di Petrarca, aiutano la forestale a trapiantare alcuni pini su una collina… tutto questo mentre Odoardo si chiede cosa siano quelle strane escrescenze sulla testa che da un po’ di tempo gli impediscono di attraversare le porte.
Durante una di queste gite Teresa gli confessa di non amare il suo promesso sposo e perciò cosa fa il nostro Jacopo? Scappa con lei in segreto e si sposano a Las Vegas? Affronta Odoardo in un duello all’ultimo sangue con le spade laser sulla Morte Nera? Anticipa Manzoni e va dal padre della ragazza dicendo: «Questo matrimonio non s’ha da fare?». Niente di tutto questo: con una mossa a sorpresa la molla e se ne ritorna all’università (evidentemente all’epoca la laurea non era solo un elegante complemento d’arredo). Qui frequenta la bella società cittadina, ha delle piccole avventure con delle donzelle, frequenta i colleghi di università ma non è felice, il suo pensiero sta sempre lì (a Teresa, che avete capito?). Per questo motivo dopo soli due mesi di corsi decide di tornare ai Colli Euganei per rivedere la sua amata che, per l’unica volta in tutto il romanzo, lo bacerà.
«Vabbè, adesso scapperanno insieme» direte voi. Ma ormai a questo punto del romanzo abbiamo capito che Jacopo ha veramente pochino in comune con Vin Diesel, anzi il ragazzo somiglia più a Steve Buscemi, infatti si ammala e non trova di meglio da fare che confessare il suo amore al padre della ragazza che ovviamente dopo questa rivelazione vorrebbe sminuzzarlo in un robot da cucina. Una volta ripresosi «…scappa con Teresa!».
Noooooooone! Jacopo si toglie il pigiama e comincia una specie di giro d’Italia, visita Bologna; Firenze, dove fa una capatina a Santa Croce per dare il suo saluto ai grandi; e soprattutto Milano. Nella città lombarda avviene il famoso colloquio con Parini, che per il ragazzo è un idolo assoluto, un Vasco Rossi senza problemi di disintossicazione. A parte l’assoluta mancanza di verosimiglianza (non è che se domani mi imbarco e parto per Bologna ho molte probabilità di parlare con Enrico Brizzi), queste pagine ci rivelano davvero il carattere del giovane Jacopo (e sotto sotto pure di Foscolo). Lo studente è veramente sdegnato per la situazione politica, per come l’Italia sia stata trattata come moneta di scambio fra due potenze straniere e auspica una rivoluzione che metta tutto a ferro e fuoco. Parini (che incarna l’altra anima di Foscolo, quella più matura) smorza subito il suo entusiasmo e gli ricorda gli esiti infausti della Rivoluzione francese, poi, visto che il ragazzo ha già un’autostima invidiabile, gli fa un discorsetto che parafrasato suona così: «Bello dello zio, tu non hai una lira e non sei nessuno. Veramente credi che i ricchi non sappiano come comportarsi in caso di rivoluzione? Quelli lo sanno meglio di te e ti sfrutteranno per ricavare il maggior vantaggio possibile dalla situazione».
Dopo aver raccolto le braccia che gli sono cadute successivamente al colloquio con Parini, Jacopo riprende il suo peregrinare per l’Italia ma alla fine decide di tornare di nuovo sui Colli Euganei dove scopre che Teresa si è sposata con Odoardo (e certo, se aspettava Jacopo…). Vinto dal dolore scrive a Teresa e, per l’ultima volta, anche al suo amico Lorenzo prima di suicidarsi con una pugnalata al cuore.
E questo era il romanzo, ma è diamo un’occhiatina a quello che è successo nel backstage.
Subito dopo la pubblicazione delle Ultime lettere di Jacopo Ortis qualche malpensante ha ravvisato delle somiglianze fra l’opera di Foscolo e I dolori del giovane Werther di Gothe. Sarà che entrambi sono romanzi epistolari? Sarà che abbiamo solo le lettere di Jacopo e di Werther ma non abbiamo le risposte dei loro amici? Sarà che i protagonisti sono due giovani che decidono di ritirarsi in campagna per dedicarsi alla Letteratura? Sarà che entrambi si innamorano di una ragazza già promessa in sposa ad un altro uomo? Sarà che a un certo punto del romanzo tutti e due lasciano il paesino per andare in città? Sarà che i romanzi finiscono con il suicidio?
Embè? Uno trova 180/190 somiglianze e subito pensa al plagio!
Tali accuse portarono Foscolo a scrivere una postfazione alla seconda edizione del romanzo, del 1804, in cui si difendeva dalle accuse di emulazione (prima si diceva così) dicendo che si era ispirato alla storia di un amico, anche se in realtà non conobbe mai Girolamo Ortis, uno studente che si suicidò e da cui lo scrittore prese in prestito il cognome per Jacopo. Hai capito che paravento, Foscolo?
Momento curiosità da giocarsi se durante gli esami/interrogazioni siete in difficoltà: dopo la pubblicazione della prima edizione ci fu un’ondata di suicidi per emulazione. Ebbene, nella postfazione del 1804 lo scrittore dovette precisare che il suo personaggio era un debole, esortando i giovani a non imitarlo. Oggi una postfazione del genere starebbe bene pure sul retro di tutti i dischi di Fedez.
A dire il vero Foscolo da Goethe ha preso anche un po’ di più di qualche spunto, tuttavia bisogna dire che, nonostante la storia sia pressoché identica, cambia l’impostazione di base: il Werther è un romanzo che si inserisce pienamente del Romanticismo, dentro vi troviamo il “mito del buon selvaggio”, una sorta di compiacimento della propria sofferenza, la vicenda amorosa è al centro di tutta la situazione, invece l’aspetto politico compare solo marginalmente. Nell’Ortis troviamo le stesse identiche tematiche solo che, al contrario, tutto il romanzo è imperniato sulla situazione politica italiana, sulle disillusioni del giovane protagonista e la storia d’amore con Teresa è quasi una scusa, una piccola “spintarella” che Foscolo dà al suo personaggio per spingerlo al suicidio, per giustificare l’atto estremo.
Per questo motivo le Ultime lettere di Jacopo Ortis non è un plagio, ma piuttosto un remake, un Werther in chiave politica e sociale, in cui si approfondiscono tematiche di un certo spessore e che forse lo rendono addirittura migliore dell’originale.
Ovviamente ciò non toglie che Jacopo Ortis per il suo tono costantemente lamentoso non avrebbe meritato di essere preso a cric sui denti per essere il progenitore di tutti i beatote attualmente presenti sul pianeta. Inclusa mia zia.
P.S.
Da notare che in tutto il post ho evitato sapientemente la battuta:
«Sai quali sono le Ultime lettere di Jacopo Ortis?»
«…is»